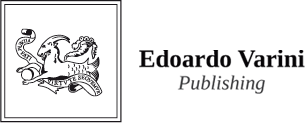Filologia del mondo nuovo
Una riflessione su Meravigliosamente di Giacomo da Lentini (II parte)
Continuiamo il nostro discorso su Meravigliosamente.
Andiamo ora a concentrarci su un rapporto più nascosto e di cui poco ancora si conosce: il rapporto tra copista e manoscritto, che in questo caso occorre moltiplicare per tre. Trattandosi di codici assai rilevanti, possiamo qui muoverci su un territorio già ben dissodato. Questi tre famosi canzonieri, infatti, si collocano con certezza verso la fine del Duecento.
Come prima si diceva, due sono conservati a Firenze (Biblioteca Nazionale Centrale, Banco Rari 217 già Palatino 418, e Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Rediano 9) e il terzo a Roma (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticano Latino 3793). Eccezion fatta per la canzone Pir meu cori alligrari di Stefano Protonotaro, per due strofe della canzone S’eo trovasse pietanza e del frammento Allegru cori plenu, entrambi di Re Enzo, copiati da un perduto Libro siciliano nella sua Arte del rimare dal filologo cinquecentesco Gian Maria Barbieri, tutti i testi dei poeti federiciani ci sono pervenuti in testimoni non siciliani.
Dei tre grandi canzonieri sappiamo che il Vaticano latino 3793 è di area fiorentina, il Laurenziano Rediano 9 di area pisana, e il Banco Rari 217 già Palatino 418 di area lucchese – a cui si aggiungono i Memoriali bolognesi (oggi accessibili nell’edizione critica di Sandro Orlando), il manoscritto Vaticano latino 3215, il Chigiano L VIII 305, la cinquecentesca “Giuntina”. Nonostante che sui tre codici in questione – com’è chiaro – siano stati scritti fiumi d’inchiostro, restano ancora dei quesiti che è bene porre in questa sede, e di cui si auspicano, nel futuro, tentativi di risposta.

Il primo ambito d’incertezza è relativo a quale codice vi sia da trascrivere. Questa, d’altronde, è la questione: i filologi moderni si accontentano sempre e soltanto della lezione che un certo manoscritto trasmette: si preoccupano, in altre parole, di ciò che un manoscritto contiene, non di ciò che il manoscritto è. Concordando con Paul Oskar Kristeller, siamo convinti anche noi che un codice in sé, pur essendo descriptus, sia portatore di un tesoro che va oltre il testo che semplicemente contiene: è testimone prezioso di una determinata epoca storica, di un’età particolare della storia della cultura ecc. Insomma: il filologo, a nostro avviso, non dovrebbe accontentarsi della lezione del manoscritto, ma anche di ciò che il manoscritto ha rappresentato nel suo preciso ambiente storico. E l’indagine, da qui, comincia ad allargarsi in maniera vertiginosa: dal codice occorrerebbe risalire all’autore, alla sua provenienza, alla sua storia, alla ricostruzione del suo rapporto con l’istituzione in cui il codice stesso è stato prodotto (monasteri, abbazie, biblioteche ecc.). Ebbene: sono rari gli studi che specificamente indagano questi temi. E se questa scarsezza interessa i codici più famosi delle origini della nostra letteratura, lasciamo facilmente immaginare quale sia lo stato degli studi riguardo a tutti gli altri manoscritti. Per queste motivazioni occorre interrogare i testi con opportune domande di certezza.
Con il progredire dei tempi, la critica testuale dovrebbe sempre più suddividere e rendere più specialistiche le fasi del proprio lavoro; dovrebbe quindi destinare ciascuna a uno studioso competente, che sia in grado di cogliere informazioni aggiuntive su un determinato codice e che abbia sempre presente, in comunione col filologo, l’obiettivo finale della critica testuale stessa: la constitutio textus.
Lo stesso dicasi riguardo al secondo ambito dell’incertezza: su cosa vale per il copista. Perché mai un copista lucchese tra la fine del Due e l’inizio del Trecento scelse un certo numero di testi da copiare? E, soprattutto, fu lui a scegliere, o i testi (ipotesi molto più probabile) gli furono commissionati? E in che termini? Questi sono quesiti che un editore dovrebbe porsi dinanzi a un manoscritto “rilevante” dal punto di vista stemmatico (e, aggiungiamo, non solo dinanzi a quelli “rilevanti”). L’elemento valutativo del copista viene messo alla prova soprattutto quando ci si trova davanti a un copista dotto, e non solo a un copista per professione (che, però, può naturalmente essere dotto). Si pensi a Petrarca, o, ancora di più, alle congetture di Poliziano (spesso esatte, ma talvolta anche errate). Relativamente ai testi siciliani, qual è stata la componente valutativa dei copisti toscani? Perché non ristudiare i manoscritti alla luce di questi ambiti, e non sempre e soltanto con l’obiettivo di fornirne solo il testo critico?
Da queste domande, come stadio ultimo, occorre giungere a quell’ambito dell’incertezza che è sovrano nella storia degli studi filologici: l’identità del copista. Dei copisti dei tre codici menzionati, infatti, conosciamo soltanto la provenienza, e questo solo da elementi linguistici contenuti negli stessi testi. Perché, invece, non provare a oltrepassare questa barriera e documentarsi in maniera più approfondita? Perché non cercare di cogliere le caratteristiche intrinseche del ductus di ciascun copista (nonostante l’omogeneità grafica medievale) e provare a delineare per lo meno i limiti cronologici in cui quel copista avrebbe potuto operare? Sono molto scarsi, se non assenti, gli studi relativi a queste problematiche. Sono domande, queste, che pur esulando dalla critica testuale in senso stretto, sono di necessaria importanza proprio alla stessa critica testuale.
Per questo, e ci preme sottolinearlo, occorre uno studio antropologico dei manoscritti. Bisogna ricordarsi che i manoscritti sono sì degli oggetti, ma oggetti sempre realizzati da uomini, con i propri limiti, caratteristiche, peculiarità. Nonostante la sua apparente aridità, la filologia dovrebbe tingersi di più umanità, proprio riconoscendo e riflettendo sul proprio status di disciplina incerta. L’antropologia dei manoscritti, se non effettiva risposta, sicuramente potrebbe essere una strada che tenda alla certezza; e che è stata pochissimo battuta dagli studiosi del XX secolo, fino a oggi. Non abbiamo la pretesa di indicare alla filologia una via per migliorare se stessa; abbiamo però il grande desiderio di allargare i suoi orizzonti; e l’ambito antropologico potrebbe essere un buon proposito di “allargamento”. Una volta conosciute le caratteristiche antropologiche di un determinato manoscritto sarebbe conseguentemente facile emendarlo di tutte le peculiarità “umane a particolari”, e volgere, quindi, alla lezione migliore: al testo secondo l’ultima volontà dell’autore. Conosciuta la formazione culturale di un certo copista, potremmo individuare molto più facilmente le banalizzazioni e gli errori dello stesso, e mostrare più sicurezza in occasione delle lectiones difficiliores.
Nondimeno, la portata storica di ogni manoscritto, come già si è detto, è senza dubbio rilevante. Pensiamo a come la Censura, o un determinato centro culturale, esprimesse i suoi veti nella trascrizione di determinate porzioni del testo. Queste sono informazioni che non possono passare inosservate, né essere studiate superficialmente; ma che rientrano luminose nel fondamentale assioma pasqualiano, per cui alla critica del testo debba obbligatoriamente unirsi la storia della tradizione.
Ma adesso basta. Ci siamo. Abbiamo raggiunto l’obiettivo.
Lorenzo Dell’Oso